Un piccolo corpus letterario per la Giornata della Memoria a scuola
di Jessy Simonini
Può risultare molto complicato definire un percorso didattico efficace e stimolante intorno alla Giornata della Memoria. Non perché manchino gli spunti: la densità della bibliografia, letteraria e saggistica, risulta quasi debordante. Una bibliografia nella quale, a ben vedere, è molto difficile muoversi, complicata per la ricchezza degli spunti e per l’interesse delle testimonianze, oltre che per le intersezioni che vengono a crearsi con lo studio della letteratura, nella sua dimensione canonica e programmatica. In che modo inserire tali ragionamenti e tali approfondimenti in un più ampio discorso sulla letteratura nella sua evoluzione storica, nel quadro di un “canone” difficile da scalfire e da deformare?
Il primo rischio sembra essere rappresentato dalla scelta di percorsi didattici già noti o già ampiamente frequentati, che possono risultare ripetitivi o poco stimolanti. Basterebbe sfogliare i cataloghi di alcune case editrici italiane per notare la messe di nuovi romanzi sulla Shoah che vengono pubblicati: operazioni commerciali astute e frequenti, che giungono sino a quasi brandizzare la memoria dell’universo concentrazionario per finalità che sono raramente di carattere etico-letterario.
Il secondo rischio è quello di limitarsi alla mera dimensione del racconto, con i suoi caratteri quasi moralistici, nel generico tentativo di restituire una testimonianza dell’esperienza concentrazionaria, una “storia vera” meritoria senz’altro di essere trasmessa, ma che non produce alcun salto in avanti di carattere etico-politico, non restituisce la complessità della storia (o, se si vuole, della Storia), non si insinua nelle pieghe possibili di un ragionamento più complesso e ampio. Si tratta forse del problema più significativo: definire un percorso memoriale e celebrativo senza che vi sia un approfondimento, senza che si ricerchi veramente la complessità e che si vada al cuore delle questioni, accontentandosi della dimensione puramente testimoniale senza ribadire quanto essa possa essere stratificata, complessa, di difficile leggibilità.
Si tratta di un rischio che non riguarda solamente la giornata della memoria e la sua possibilità di costruire intorno a questa data simbolica un percorso didattico-letterario. Sicuramente ciò vale anche per il racconto della resistenza e, più in generale, per il racconto dei traumi del Novecento. Un certo approccio tutto concentrato sul valore della testimonianze, sul trasmissione di storie vere può senz’altro avere un valore, ma il rischio è quello di ridurre la questione alla storia di una soggettività isolata, senza entrare più nel profondo nell’ordito della Storia, questo “scandalo che dura da diecimila anni” (riprendo le amare parole di Elsa Morante), di cui sarebbe utile restituire alcuni aspetti un po’ diversi, divergenti, anche problematici.
Questo aspetto è ancor più vero per il racconto dell’universo concentrazionario e della Shoah, giacché la letteratura del secondo Novecento non si è affatto limitata alla mera raccolta di testimonianze, ma ha piuttosto rappresentato un terreno di sperimentazione letteraria e linguistica o lo spazio di un più ampio ragionamento etico o meta-letterario sulla memoria e sui suoi inganni (penso, ad esempio, a Ruth Kluger ad alcuni dei suoi libri, fra cui weiter leben. Eine Jugend, di cui aspettiamo una traduzione in italiano e che oggi è accessibile in francese, con il titolo di Refus de témoigner; e penso pure a Franco Fortini).
Per questo motivo, sulla base delle mie esperienze di studio e di attività laboratoriali condotte a scuola, ho tentato di definire un ridotto corpus meramente letterario dedicato in prevalenza alle scuole secondarie di secondo grado, ma senz’altro estendibile anche a quelle di primo grado; un corpus forse diverso da quello che normalmente viene selezionato per la trasmissione del racconto sulla Shoah e sull’universo concentrazionario nazista, ma che mi pare utile presentare. In prima istanza, per consentire la scoperta di altri autori e, soprattutto, di altre autrici che normalmente non vengono presi/e in considerazione. In secondo istanza per definire uno spazio più ampio, che non si limiti solamente all’approccio moralistico-testimoniale cui facevo riferimento in precedenza, ma che si diriga verso sentieri nuovi, inesplorati.
Perché la giornata della memoria esca dalla sua dinamica meramente celebrativa, dall’abbacinante, rassicurante pratica del “ricordo”; ma al contrario per proporre uno sguardo più politico e critico, legato alle evoluzioni della storia letteraria e anche alla riflessione di carattere metapoetico sulla memoria della Shoah. È in quest’ottica che occorrerà leggere il corpus in questione, affinché la giornata della memoria non sia più semplicemente un’occasione celebrativa dai tratti lapidari, ma un’opportunità per riflettere sulla memoria come categoria politica e letteraria, come spazio di negoziazione e di conflitto (atroce, in alcuni casi) necessario per ridefinire il nostro rapporto con la contemporaneità. Forse sarà questa la direzione da percorrere, in futuro.
Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra

La letteratura francese dell’immediato dopoguerra è senz’altro attraversata dall’esigenza di raccontare l’esperienza autobiografica dei campi di concentramento. Esiste già una bibliografia piuttosto ampia, nella quale possiamo inserire un autore come Robert Antelme (L’Espèce humaine) e la stessa Marguerite Duras, con La Douleur, pubblicato nel 1985, dove riemerge la figura dello stesso Antelme, suo compagno, di ritorno dai campi di concentramento nazisti.
Charlotte Delbo (n. 1913), di origini italiane, viene deportata ad Auschwitz per ragioni politiche. Negli anni trenta partecipa all’attività politica del Partito comunista e dopo l’occupazione si unisce alla resistenza, venendo poi imprigionata e deportata nel campo.
Il libro di Delbo, prima parte di un più ampio lavoro dal titolo Auschwitz et après uscito a partire dagli anni Sessanta, si configura come il tentativo di restituire, attraverso la scrittura, una parte della propria esperienza fisica, corporea, all’interno del campo di concentramento. Per restituire la propria storia, l’autrice sceglie una forma inattesa, non la prosa narrativa delle cronache e dei racconti tradizionali, ma piuttosto la forma poetica, che si sostanzia in un prosimetro efficace, in un’architettura testuale complessa, di certo non imbrigliabile nello spazio lineare della prosa.
Questa specie di prosimetro, che alterna passaggi in prosa a una versificazione scabra ed essenziale, sembra inserirsi in una dimensione nuova, una forma di prosa poetica che mi pare unica nell’ambito delle narrazioni contemporanee sullo stesso tema. Come rimarca Maria Giovanna Bertani, insegnante del Liceo Laura Bassi di Bologna che ha condotto una significativa esperienza didattica proprio a partire dal testo di Delbo, Auschwitz et après si presta bene ad essere utilizzato in un contesto formativo. Sia per il valore assoluto della testimonianza di Delbo, nella sua unicità, sia per la possibilità di studiare le modalità e le pratiche testuali attraverso cui tale testimonianza si dispiega.
In primo luogo, la già citata scelta di un linguaggio poetico, fortemente simbolico o simbolistico, che deforma la prosa, la ripensa e ne fa qualcosa di completamente nuovo, seguendo una tendenza già percorsa da altri autori nel piano europeo (si può pensare ad esempio al Nouveau Roman o al romanzo La Figlia prodiga di Alice Ceresa, che viene pubblicato nel 1967 e che ha una analoga costruzione stilistica). In secondo luogo, la scelta di una narrazione che non si costruisce alla prima singolare, ma piuttosto alla prima plurale: un noi ampio, corale, smagliato, che si estende sino al voi del lettore, in un continuo interpellare l’altro, colui che deve accogliere e ricevere la testimonianza nella sua complessità.
E questo noi determina quasi uno scivolamento indietro della soggettività narrante, che viene in parte ad annullarsi : in questa prospettiva la testimonianza non è più quella di una sola soggettività, ma è una memoria più aperta, più condivisa, quella dei “noi” evocati nel titolo, dei quali nessuno tornerà perché, comunque vada, le cose non potranno mai tornare quelle di prima.
Link ad articolo Bertani: https://dsrivista.unibo.it/article/view/10764
Luce d’Eramo, Deviazione

Deviazione di Luce d’Eramo è forse un libro unico nel proprio genere, perché unico è il tracciato biografico della sua autrice. Nata in Francia in una famiglia di origini italiane, D’Eramo torna presto in Italia, a Roma, dove si iscrive ai GUF ed è una fervente militante fascista. Una militanza, quella di D’Eramo, che la spinge a intraprendere una scelta radicale: andare in Germania, lavorare come volontaria in un campo di lavoro tedesco. E dopo la fuga dal campo, D’Eramo si unisce volontariamente a un convoglio diretto a Dachau, distruggendo i propri documenti:
Ho presto detto – finché me ne sono convinta – che dopo lo sciopero era stata deportata a Dachau coi compagni. Ho soprattutto sepolto l’atto compiuto in quel lontano 2 agosto a Verona come qualcosa da cancellare. Volevo che m’avessero catturata e rinchiusa i nazisti, al punto che a poco a poco anche il mio primo volontariato s’è perso nel vago, i mesi all’IG Farben si sono annebbiati e persino il soggiorno al K-Lager di Dachau è scivolato nell’ombra, quasi contenesse situazioni che mi costringevano a rammentare il resto (p. 268).
Se Deviazione può configurarsi come una sorta d’autobiografia stratificata, costruita attraverso Lucia, avatar dell’autrice, il racconto dell’esperienza concentrazionaria si muove su due sentieri paralleli. Il primo è più intellettuale, un tracciato formativo verso la progressiva decostruzione di sé e della propria identità politica da parte di una giovane donna d’ascendenza borghese (figlia di un sottosegretario dell’RSI), risoluta nelle sue certezze sul nazifascismo, intenzionata a smontare l’universo di “bugie” sulla Germania e sui campi di cui iniziava a giungere un’eco. In quest’ottica, il libro è prima di tutto un apprendistato intellettuale di decostruzione che combacia con la scoperta di sé e della realtà.
Il secondo aspetto che occorre citare in questa sede riguarda la dimensione del corpo, giacché Deviazione non si stacca mai da una prospettiva organica, corporea; quella di un corpo esposto, mostrato senza filtri, il corpo ferito e rotto della protagonista Lucia, rimasta semiparalizzata dopo un bombardamento alleato.
Deviazione resta tuttavia, in prevalenza, la storia di una rimozione, di un offuscamento della memoria, nel manifestarsi di un vero e proprio conflitto “tra la mia memoria e la mia scrittura” (sono parole dell’autrice) che si definisce solo molti anni dopo la fine dell’esperienza concentrazionaria, in più fasi. L’interesse di uno studio di questo testo in classe risiede proprio nella possibilità di approfondire un’esperienza intellettuale di decostruzione faticosa (fisicamente e psicologicamente) delle proprie idee e del proprio sistema di valori, alle difficoltà nel raccontarlo, nel fare un libro a partire della propria storia personale taciuta per decenni.
Per un approfondimento su Deviazione, si veda quest’utile contributo di Daniela Ambrosino: https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/4461#ftn90
Anna Maria Ortese, “Il diario di Anna Frank rimane un libro aperto” in Da Moby Dick all’Orsa Bianca
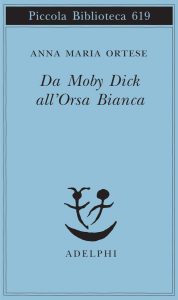
Questo breve saggio di Ortese, originariamente pubblicato su un’edizione del Notiziario Einaudi del 1954 in corrispondenza dell’uscita in Italia del Diario, permette di affrontare la questione approfondendo un aspetto della critica letteraria e, più precisamente, della critica d’autore nel corso della seconda metà del Novecento. Nei testi ortesiani, almeno all’apparenza, la storia sembra essere assente, o quantomeno asciugata, ristretta, generando costruzioni narrative che aboliscono sovente la cronologia e si situano su un territorio per sua natura “altro”. Questo non vale forse per i racconti de Il Mare non bagna Napoli, cronache di uno spaesamento, sì, ma inserite in un preciso cronotopo.
Abbiamo già scritto, in passato, della possibilità di impostare un percorso didattico su Anna Maria Ortese in classe (https://site.unibo.it/griseldaonline/it/didattica/magda-indiveri-jessy-simonini-popolo-mite-anna-maria-ortese) ; in questo caso sarà utile considerare un breve saggio sul Diario di Anna Frank, di cui Ortese mette in luce alcuni aspetti significativi, identificando nella figura di Anna un’immagine universale di ragazzina di fronte alla storia.
“Anna possiamo figurarcela guardando le sue fotografie e soprattutto pensando alle ragazzine di tutti i tempi e i Paesi, su quell’età: non più bambine né ancora donne, esseri di mezzo, franchi, spiritosi, dispettosi, gentili, sensibili, pieni di energia e di disperazione, di curiosità e di smanie, avidi di apprendere, di essere, di capire, perennemente disgustati e divertiti, disorientati e incantati, attratti e respinti da mille cose: il cielo, la gente, i libri, papà e mamma, quei piccoli uomini che sono i compagni, quei grandi ragazzi che sono gli adulti. Insieme alla natura, alla gente, alle cose, stupore per la propria persona: il corpo che cresce come un albero, gli occhi, le mani, i pensieri.”
Per Ortese, il Diario resta un libro “aperto”, per la sua capacità di generare una speranza, giacché esso “non ci lascia un senso di pena” ma al contrario si apre verso il futuro e ci spinge verso l’orizzonte.
Patrick Modiano, Dora Bruder

Quest’ultimo testo, tradotto in Italia da Guanda, è prima di tutto un testo sulla memoria e sul suo rarefarsi nella disperata ricerca di Dora, di una traccia di Dora, da parte dell’autore. Una ricerca poco fruttuosa, nell’assenza di fonti e di strumenti di lavoro utili (solo qualche ricordo lontano, qualche lettera, qualche documento d’archivio).
Il punto di partenza resta una traccia materiale, la scomparsa di una bambina ebrea a Parigi, nel pieno dell’occupazione: Dora Bruder, appunto, di cui Modiano legge su una copia di un vecchio giornale del 1941.
Il libro si configura come un’indagine insieme geografica e storica. Sembra infatti che il cuore del romanzo sia proprio quello geografico o topografico, poiché la quête di Dora passa anche dal paesaggio, in ciò che dietro il paesaggio sembra nascondersi. Modiano tenta così di ricostruire il suo percorso nel giorno della scomparsa; il paesaggio urbano che la circondava nel corso della sua permanenza al pensionnat cui i genitori l’avevano affidata; i luoghi intorno a Boulevard Ornano abitati dalla famiglia di Dora e ben noti allo stesso autore. Il testo è ricco di riferimenti al paesaggio urbano di Parigi, alle trasformazioni conosciuto dalla città, alla scomparsa del ricordo di Dora nei luoghi e negli spazi che aveva abitato- come ricorda Ernaux, del resto, “tutte le immagini scompariranno”.
Il lavoro di scrittura di Patrick Modiano si dispiega poi su molteplici piani : quello della documentazione storiografica, con la presenza nell’ordito narrativo di tracce d’archivio e anche di riferimenti diretti ai documenti amministrativi che ci forniscono una testimonianza di Dora e della propria famiglia, oltre che del loro percorso durante l’occupazione. Ma questi documenti, queste tracce non sono mai sufficienti, restano parziali, provvisorie; sono piuttosto un punto di partenza per aprirsi, poi, a una riflessione sul rovescio delle carte d’archivio : la narrazione di ciò che è oltre la memoria materiale, oltre il lessico neutro e cartesiano dell’amministrazione pubblica. E la scrittura « di memoria » trova spazio nella rottura, a partire da altre immagine legate alla città e all’esperienza della soggettività autoriale, di cui ci sono esempi numerosi in tutto il romanzo e che si mescolano, poi, ad altre voci e ad altre fonti.
Scrive Modiano:
« Da anni tento…[di] scrivere una biografia, un reportage, di indagare su un avvenimento reale…[In Dora Bruder], ho sentito che mi avvicinavo a un qualcosa che non sarebbe stato un romanzo. Ma, privo di elementi, sono stato obbligato a cucire, a diluire il vero in una specie di minestra. Vorrei avere un dossier come quelli degli avvocati, un dossier pieno di documenti, di rapporti di polizia, di deposizioni di testimoni, di conclusioni di esperti. In quel caso non avrei più bisogno di utilizzare la finzione”
La scrittura, la narrazione, arrivano dove la storia non può arrivare, dove le tracce materiali non consentono di ricostruire la storia di Dora Bruder: la letteratura si sostituisce alla testimonianza e l’opera dello scrittore è prima di tutto quella di uno scandaglio, nel tentativo di proporre una verità che si costruisca nello spazio della narrazione e che solo in esso possa esistere, per far rivivere queste tracce rarefatte e imprendibili.
Alcuni supporti testuali
- Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra
« RUE DE L’ARRIVÉE, RUE DU DÉPART
Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu’ils sont fatigués du voyage.
Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants.
Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent.
Il y a un café qui s’appelle « À l’arrivée » et un café qui s’appelle « Au départ ».
Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent.
Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent
une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus.
C’est la plus grande gare du monde.
C’est à cette gare qu’ils arrivent, qu’ils viennent de n’importe où.
Ils y arrivent après des jours et après des nuits
ayant traversé des pays entiers
ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devaient pas être du voyage.
« Ils ont emporté les enfants parce qu’on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là.
Ceux qui en avaient ont emporté de l’or parce qu’ils croyaient que l’or pouvait être utile.
Tous ont emporté ce qu’ils avaient de plus cher parce qu’il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin.
Tous ont emporté leur vie, c’était surtout sa vie qu’il fallait prendre avec soi.
Et quand ils arrivent
ils croient qu’ils sont arrivés
en enfer
possible. Pourtant ils n’y croyaient pas.
Ils ignoraient qu’on prît le train pour l’enfer mais puisqu’ils y sont ils s’arment et se sentent prêts à l’affronter
avec les enfants les femmes les vieux parents avec les souvenirs de famille et les papiers de famille.
Ils ne savent pas qu’à cette gare-là on n’arrive pas.
Ils attendent le pire – ils n’attendent pas l’inconcevable.
- Patrick Modiano, Dora Bruder
[Estratto I]
« Il venticinque febbraio millenovecentoventisei, alle ore ventuno e dieci, è nata, in rue Santerre 15, Dora, di sesso femminile, da Ernest Bruder nato a Vienna (Austria) il ventuno maggio milleottocentonovantanove, manovale, e da Cécile Burdej, nata a Budapest (Ungheria) il diciassette aprile millenovecentosette, disoccupata, sua moglie, domiciliati a Sevran (Seine-et-Oise), avenue Liégeard 2. Redatto il ventisette febbraio millenovecentoventisei, ore quindici e trenta, dietro dichiarazione di Gaspard Meyer, settantatré anni, impiegato e domiciliato in rue de Picpus 76, che ha assistito al parto e, presa visione, ha firmato con Noi, Auguste Guillaume Rosi, vicesindaco del dodicesimo Arrondissement di Parigi. » Il 15 di rue Santerre è l’indirizzo dell’ospedale Rothschild. Nel reparto maternità di questo ospedale sono nati, nello stesso periodo di Dora, molti bambini di famiglie ebree povere che erano appena immigrate in Francia. Sembra che Ernest Bruder non si sia potuto assentare dal lavoro per dichiarare personalmente la nascita della figlia quel giovedì 25 febbraio 1926, al municipio del 12° Arrondissement. Forse su qualche registro si potrebbero trovare indicazioni concernenti quel Gaspard Meyer che ha firmato in calce all’atto di nascita. Il 76 di rue de Picpus, dove era “impiegato e domiciliato”, era l’indirizzo dell’ospizio Rothschild, creato per i vecchi e gli indigenti.
Le tracce di Dora Bruder e dei suoi genitori, in quell’inverno del 1926, si perdono nella periferia nordorientale, sulle rive del canale dell’Ourcq. Un giorno andrò a Sevran, ma temo che lì le case e le strade abbiano cambiato aspetto, come in tutte le periferie. Ecco i nomi di alcuni esercizi, di alcuni abitanti di rue Liégeard a quell’epoca: il Trianon di Freinville occupava il 24. Un bar? Un cinema? Al 31, c’erano le Caves dell’lle-de-France. Un dottor Jorand era al 9; un farmacista, Platel, al 30.
Rue Liégeard, dove abitavano i genitori di Dora, faceva parte di un agglomerato che si stendeva sui comuni di Sevran, di Livry-Gargan e di Aulnay-sous-Bois, e che era stato chiamato Freinville. Il quartiere era nato attorno alla fabbrica di freni Westinghouse, impiantata lì all’inizio del secolo. Un quartiere operaio. Aveva cercato di acquisire l’autonomia amministrativa negli anni Trenta, senza riuscirci. Allora aveva continuato a dipendere dai tre comuni limitrofi. Aveva comunque la sua stazione: Freinville.
Ernest Bruder, padre di Dora, era sicuramente, in quell’inverno del 1926, manovale nella fabbrica di freni Westinghouse.
[Estratto II]
Per lungo tempo non ho saputo più niente di Dora Bruder, di cosa le era accaduto dopo la fuga del 14 dicembre e l’annuncio di ricerca pubblicato su “Paris-Soir”. Poi ho appreso che era stata internata nel campo di Drancy, otto mesi dopo, il 13 agosto 1942. Sulla scheda era indicato che proveniva dal campo delle Tourelles. Quel 13 agosto 1942, in effetti, trecento ebree erano state trasferite dal campo delle Tourelles a quello di Drancy.
La prigione, il “campo”, o meglio il centro d’internamento delle Tourelles occupava i locali di un’ex caserma di fanteria coloniale, la caserma delle Tourelles, al 141 di boulevard Mortier, alla Porta dei Lilas. Era stato aperto nell’ottobre del 1940 per internarvi gli ebrei stranieri in situazione “irregolare”. A partire dal 1941, però, quando gli uomini verranno mandati nei campi del Loiret, soltanto le donne ebree che avessero contravvenuto alle ordinanze tedesche sarebbero state internate alle Tourelles, assieme alle comuniste e alle “comuni”.
In quale momento, e per quali motivi precisi, Dora Bruder era stata mandata alle Tourelles? Mi chiedevo se non esistesse un documento, una traccia in grado di fornirmi una risposta. Ero costretto alle supposizioni. Sicuramente l’avevano arrestata per strada. Nel febbraio del 1942 – erano trascorsi due mesi dalla sua fugai tedeschi avevano emanato un’ordinanza con cui si proibiva agli ebrei parigini di lasciare il loro domicilio dopo le venti e di cambiare indirizzo. La sorveglianza nelle strade era dunque diventata più severa rispetto ai mesi precedenti. Avevo finito col convincermi che Dora si era fatta prendere proprio in quel gelido e lugubre mese di febbraio, quando la Polizia delle Questioni ebraiche si appostava nei corridoi del metro, all’ingresso dei cinema o all’uscita dei teatri. Mi sembrava addirittura sorprendente che una ragazza di sedici anni, della cui scomparsa e dei cui connotati la polizia era al corrente fin dal dicembre, fosse riuscita a sfuggire alle ricerche per tutto quel tempo. A meno che non avesse trovato un nascondiglio. Ma quale nella Parigi dell’inverno 1941-1942, il più tenebroso e duro inverno dell’Occupazione, con la neve che aveva cominciato a cadere a novembre, con una temperatura vicina ai quindici gradi sottozero, con l’acqua gelata dappertutto, il vetrato per le strade, e di nuovo, e in grande abbondanza, la neve nel mese di febbraio? Quale poteva essere il suo rifugio? E come riusciva a sopravvivere in quella Parigi?
Era in febbraio, pensavo, che “loro” dovevano averla presa nelle loro reti. “Loro”: poteva trattarsi tanto di semplici vigili urbani quanto della Brigata dei Minori o della Polizia delle Questioni ebraiche intenti a fare un controllo d’identità in qualche luogo pubblico… Avevo letto in una raccolta di verbali che alcune ragazze di diciotto o diciannove anni erano state mandate alle Tourelles per lievi infrazioni alle “ordinanze tedesche”, e fra di esse c’erano anche delle sedicenni, coetanee di Dora… Quel mese di febbraio, la sera dell’entrata in vigore dell’ordinanza tedesca, mio padre era stato preso in una retata sugli Champs-Elysées. Alcuni ispettori della Polizia delle Questioni ebraiche avevano bloccato le uscite di un ristorante di rue de Marignan dove lui stava cenando con un’amica. Avevano chiesto i documenti a tutti gli avventori. Mio padre ne era privo in quel momento. Lo avevano prelevato. Nel cellulare che lo portava dagli Champs-Elysées a rue Greffulhe, sede della Polizia delle Questioni ebraiche, aveva notato, fra altre ombre, una ragazza di circa diciott’anni. L’aveva persa di vista quando erano stati fatti salire al piano dell’edificio occupato dalla centrale di polizia e dall’ufficio del capo, un certo commissario Schweblin. Poi era riuscito a scappare, approfittando di un’interruzione di corrente, mentre scendeva le scale per essere portato al Deposito.


 English
English



